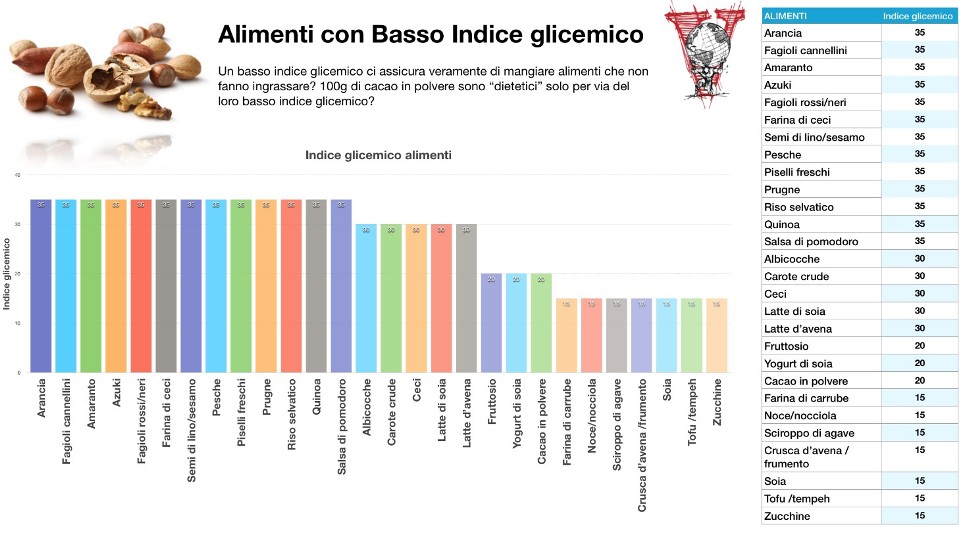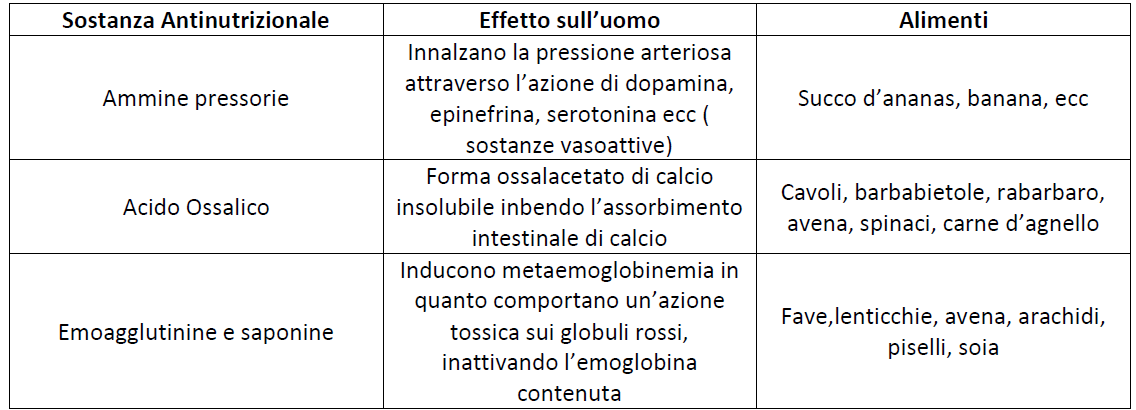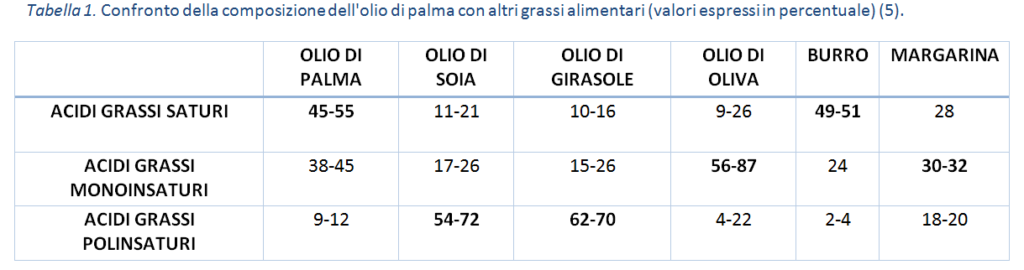Ci sono tantissimi buoni motivi per seguire le stagioni nelle nostre scelte alimentari.
Prima di tutto, spiegare nel dettaglio l’esatta stagionalità del carciofo ci conferisce quell’aria da “contadino, scarpe grosse e cervello fino”, che serve sempre a far bella figura. In secondo luogo, chi preferirebbe quelle palline rosse insapori, che a dicembre chiamano pomodori, rispetto ai succosi e saporiti cuore di bue che troviamo d’estate? Se per voi l’aspetto organolettico non è una motivazione sufficiente, lo sarà senz’altro l’aspetto nutrizionale. I vegetali che giungono a maturazione completa con i tempi e le temperature adeguati sviluppano tutte quelle sostanze (leggi: vitamine, minerali, acidi organici, fitonutrienti, macronutrienti e via dicendo) che non solo servono alla pianta, ma sono anche benefiche per il nostro organismo e fondamentali per una dieta sana ed equilibrata. Se invece la maturazione è “forzata” o addirittura non raggiunta, la pianta non svilupperà tali sostanze, o comunque non nelle quantità che ha normalmente. A questo proposito, qualcuno di voi si chiederà: se un vegetale viene raccolto in un paese dove in questo momento “è stagione” vuol dire che è comunque giunto a maturazione, che cosa cambia alla fine? In questo caso il punto è la freschezza: è facile intuire che i vegetali che giungono da altri paesi o continenti sono sottoposti a viaggi di giorni e giorni e molti di questi vengono conservati a lungo in celle frigo. I micronutrienti presenti negli alimenti sono piuttosto fragili (chi più chi meno) e variazioni di temperatura, di luce, urti, il passare stesso del tempo portano a una perdita significativa in termini di valore nutrizionale. Dunque, generalmente, meno tempo è passato da quando un vegetale è stato raccolto a quando è giunto sulla nostra tavola, meglio è. Certamente, non tutti abbiamo il lusso di avere sotto casa un rigoglioso orto, dunque è bene fare scelte oculate nei nostri acquisti. Ulteriore aspetto nutrizionalmente positivo nel seguire la stagionalità dei cibi: la varietà. Il fatto che pochi cibi crescano indifferentemente tutto l’anno, ci obbliga a modificare le nostre scelte e la gamma di piatti preparati quasi ogni mese. E ciò è davvero un toccasana per la nostra salute. Non esiste, infatti, l'alimento "completo" o "perfetto" che contenga tutte le sostanze indispensabili alla nostra salute e che sia quindi in grado di soddisfare da solo le nostre necessità. Perciò, il modo più semplice e sicuro per garantirci l'apporto di tutti gli elementi nutritivi è quello di variare il più possibile le nostre scelte alimentari. Così facendo, non solo evitiamo il pericolo di squilibri nutrizionali e delle loro conseguenze sulla nostra salute, ma soddisfiamo anche maggiormente il nostro palato, combattendo la monotonia dei sapori. Inoltre, variare sistematicamente e razionalmente le scelte dei cibi significa ridurre un altro rischio che può derivare da abitudini alimentari monotone, vale a dire l’ingestione ripetuta e continuativa – mangiando sempre gli stessi alimenti – sia di sostanze estranee eventualmente presenti, sia di composti "antinutrizionali" in essi naturalmente contenuti. Per di più, non richiedere al mercato sempre gli stessi prodotti (e le stesse varietà dello stesso prodotto, per giunta) fa sì che incentiviamo a proteggere l’incredibile biodiversità dei vegetali italiani. Se anche l’aspetto nutrizionale non vi sprona a seguire il calendario, perché non parlare del portafogli? Sì perché chi mangia di stagione risparmia! Infatti, nel prezzo finale della verdura e della frutta fuori stagione che oggi abbonda nei reparti del supermercato verranno necessariamente inclusi maggiori costi produttivi (ad esempio per gli strumenti necessari a crescere un vegetale in un clima diverso dall’usuale, come maggiori prodotti fitosanitari o serre riscaldate), maggiori costi di conservazione (come quelli legati alle celle frigo nelle quali i prodotti fuori stagione perdurano per più tempo) e maggiori costi di trasporto (che sia da una regione diversa d’Italia, da un Paese estero o addirittura da un altro continente). E tutto ciò non si ripercuote solamente sulle nostre tasche, ma anche sul nostro amato Pianeta, in termini di energia (non pulita) consumata e CO2 prodotta. Vediamo dunque cosa ci riserba ogni stagione!

Dato che siamo già ad aprile, iniziamo con la primavera. Il risveglio della natura ci regala i saporiti asparagi, ricchi di carotenoidi e acido folico, i cetrioli, i fagiolini, gli zucchini, le melanzane, i ravanelli e i carciofi, quest’ultimi già presenti dall’inverno, con la loro importante ricchezza di fibra, potassio e acido folico. Se una ciliegia tira l’altra è meglio che lo faccia in questa stagione, perché sarà più ricca di carotenoidi, antocianine e vitamina C. Iniziano a esserci anche meloni e angurie, più caratteristici però dell’estate. Protagoniste della primavera (ma anche dell’estate) sono le gustose fragole, con il loro prezioso apporto di carotenoidi, antocianine, quercetina e vitamina C. Fra inverno e primavera troviamo il pompelmo, mentre a cavallo fra primavera ed estate spuntano le arancioni albicocche, non a caso campionesse di carotenoidi, ma anche di potassio e vitamina C.

Il tripudio della vegetazione continua con l’estate. Inizia qui la raccolta dell’aglio, immancabile nella dieta Mediterranea, con il suo caratteristico odore e sapore dato dai benefici composti solforati: l’aglio sarà “di stagione” anche nel successivo autunno, ma possiamo considerarlo un vegetale annuale perché la conservazione per tutto l’anno non ne altera le proprietà. Insieme a lui, come non ricordare le cipolle, maestre dei nostri soffritti e fonti della benefica quercetina? Ma il protagonista indiscusso della cucina Italiana è senz’altro il pomodoro, re dell’estate con il suo potente e rosso licopene. Già presenti in primavera, ricordiamo i saporiti peperoni, fra le verdure più ricche di vitamina C. Proseguono i cetrioli, i fagiolini, gli zucchini, i ravanelli e le melanzane, il colore di questi ultimi dato dalle benefiche antocianine. Già dalla primavera iniziamo a vedere pesche e susine, ma è l’estate la loro stagione predominante. Stesso discorso vale per melone e anguria, fedeli compagni delle nostre afose giornate estive. Estivi sono anche i frutti di bosco: more, mirtilli, lamponi e ribes non sono solo belli a vedersi sulle nostre crostate, ma anche estremamente benefici con la loro ricchezza di fibra, magnesio, vitamina C e antocianine. D’estate si caricano di frutti anche le rigogliose vigne: approfittiamone, l’Italia è il Paese al mondo dove si produce più uva, la cui vendemmia prosegue anche nell'autunno.

Rimaniamo quindi in tema e parliamo dei vegetali che ci regala questa colorata stagione. Protagonisti dell’autunno sono i due frutti bianchi, già presenti in estate e che proseguiranno anche in inverno: le pere e le mele, che veramente ci tolgono il medico di torno, perché fonti preziose di fibra, vitamina C e quercetina. Ma abbiamo anche un simpatico frutto arancione: il dolce caco, che ha questo colore proprio per la sua ricchezza di carotenoidi. Come non citare poi l’autunnale castagna? Racchiusa nel suo riccio spinoso, non è ricca d’acqua come il resto della frutta, ma d’amido, ed è per questo che se ne ricava anche una farina con cui preparare piatti prelibati. Col loro odore non esattamente piacevole, ci accompagneranno per tutto l’autunno e l’inverno successivo i bianchi cavolfiori, ricchi di fibra, potassio e vitamina C e i verdi broccoli, fonti preziose non solo di fibra, potassio e vitamina C, ma anche di carotenoidi, vitamina K e dei potenti composti anticancro della famiglia delle Crucifere, i glucosinolati. Inizieranno poi a esserci anche agrumi e kiwi, ma anche zucche, sedano, cardi, cicoria e radicchio, i quali però saranno i protagonisti dell’inverno. Super autunnali sono invece i porri, gustosi e ricchi di fibra e potassio, e i fichi, fonti eccezionali di carotenoidi, antocianine e magnesio.

Concludiamo la nostra carrellata di sapori con quelli della fredda stagione invernale. A scaldarci saranno sicuramente la vasta gamma di minestre, minestroni, creme e zuppe a base di Crucifere, di cui fanno parte i già citati cavolfiore e broccolo, ma anche i cavoli e le verze, protagonisti veri dell’inverno. Il cavolo, in particolare, ci apporterà dosi massicce di vitamina C (se consumato crudo però!), ma anche di vitamina K e, i già citati, glucosinolati. Se la vitamina C delle Crucifere non vi bastasse, perché non attingere a quella dei molto più famosi agrumi, re dell’inverno. Arance, limoni, mandarini e mandaranci, per non parlare del peloso kiwi saranno un toccasana per la nostra salute. Concludiamo l’inverno in bellezza con rape, sedano, cardi e radicchio, quest’ultimo fonte eccellente di fibra e carotenoidi, come pure l’arancione zucca e le sue gustose creme.

Per non sbagliarvi, tenete a mente che ci sono vegetali che sono “di stagione” praticamente tutto l’anno. Con questi non farete mai brutta figura. Parliamo delle biete e degli spinaci, che a Braccio di Ferro non facevano solo crescere i muscoli, ma apportavano soprattutto fibra, potassio, vitamine C e K, acido folico e gli immancabili carotenoidi. Parlando di carotenoidi non possiamo dimenticare la carota, che il simpatico Bugs Bunny può sgranocchiarsi tutto l’anno. Stesso discorso per patate, legumi secchi, finocchio ed erbe aromatiche. Concludiamo con un vegetale immancabile sulla tavola degli italiani, ricco di carotenoidi, vitamina K, potassio, vitamina C e acido folico: la nostra cara insalata, il contorno che sta bene con tutto e che ci salva tutte le cene improvvisate.
Questo articolo non vuole essere una lezione sulle stagioni, ma un invito a essere curiosi sulla ricchezza che ci offre la Natura. In un mondo dove i bambini credono che la melanzana nasca già sotto forma di parmigiana, proviamo a insegnar loro da dove proviene il cibo, quando e come nasce, quale duro lavoro c’è dietro. Raccontiamo loro la storia di ogni singolo boccone e in futuro saranno consumatori consapevoli.
ELENA FERRERO
Fonti:
- l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANA, revisione 2003.
- verduredistagione.it
- slowfood.it